Il tratteggio:
Nella sua perspicua e illuminante prefazione, Anna Maria Curci propone la parola tedesca schweben, “fluttuare, stare in bilico, esser sospesi”, come chiave di lettura di questo testo e della intera poesia di Cristina Bove. Seguo questo suggerimento e aggiungo altri due termini, sempre di ambito tedesco: Ausdruck: “espressione, frase, detto” ma anche “sguardo e voce”. Da cui Ausdruckweise: “fraseggio”. E poi Abgrund: “abisso, pendio, precipizio, salto nel blu.” Etimologicamente “assenza di fondamento”. Filosoficamente, quest’ultimo termine indica infatti il fondamento nullo del nostro essere al mondo, tra realtà biologica e rappresentazione psicosociale: la terribile simmetria del vuoto. Tra fluttuazione e spro-fondamento dell’esserci si svolge infatti il fraseggio poetico di Cristina Bove.
Una triangolazione fra le costellazioni semantiche di Ausdruck, Schweben e Abgrund (espressione, bilico e abisso) può svelarci il luogo proprio e offrici l’orientamento di fondo della versificazione di Cristina Bove, cioè anche una cartografia del suo dire (Dichtung). C’è infatti nel termine Ausdruck (espressione, manifestazione, frase) un nesso fra sguardo e voce, assente nei suoi corrispettivi italiani, che implica quel cooperare nell’espressione poetica dell’occhio e della mano, che Walter Benjamin già indicava come la virtù precipua dell’antico cantastorie, il suo saper trarre da una tradizione condivisa le formule verbali e le alchimie del verso e della performance, il suo saper catturare e tenere avvinti gli ascoltatori nel giro della frase, nella reciprocità degli sguardi, nella cerchia dell’ascolto, che è la base di ogni circolo ermeneutico. Da qui parte la mia ipotesi: il dettato (Dichtung) di Cristina Bove sta sempre in bilico sull’abisso del proprio esserci. Una ipotesi che coniuga quell’esitazione fra suono e senso che Valery indica come carattere saliente della poesia, con la sua funzione primaria di testimonianza e terapia della finitudine e precarietà dell’essere al mondo insieme ad altri.
Una poesia della soglia, dunque, e del filo: liminale e sorvegliata. Filata sulla sottile ragnatela del carro della regina Maab (in Sogno di una notte di mezza estate) ma anche tessuta con la dedizione e la sapienza con cui Penelope tesse e disfa quella tela che è il sostrato comune del canto di tutti gli aedi dell’Odissea, Ulisse compreso. Una struttura flessibile, leggera e ferrea, come quella di un ponte d’acciaio teso sopra l’abisso. Quando indicherò nella maestria del fraseggio (Ausdruckweise) una sua virtù caratteristica, intenderò anzitutto questo convenire dello sguardo e della voce, questo accennare, nell’intervallo minimo fra pause e battute del verso, a un altrove, a quel fondo da cui emergono tutte le sue nitide figure, nel saper cogliere il tempo giusto (kairòs) perché la grazia (charis) della parola incarnata risulti efficace. Il dettato di Cristina Bove è danza graziosa sull’abisso che si intravede nella luminosa trama (nell’ultrasenso e nell’oltreluce) delle sue figure, nel chiaroscuro impeccabile, dei suoi versi.
Questa espressione dell’esserci come esser tra, frammezzo, sospeso e intrappolato nello stesso atto del dire, di tracciare percorsi e indicare luoghi, e costruire una dimora per abitarla, è forse il senso eminente di questa simmetria del vuoto. I suoi versi intrecciano una danza fra dettaglio e disegno, fra macro e microcosmo, dove risuona, nella squisita e tenace volontà di forma dell’io poetico, l’eco sfinita della risata tragica dell’es stretto “nel labirinto delle sue mutazioni”. (13) In una serie di attributi felicemente variati di un soggetto-fondamento mancante, volatile, spro-fondante appunto in un interminabile salto nel blu – quel colore che pare essere il preferito della nostra autrice, a giudicare dalle composizioni di videoarte che spesso ne accompagnano i versi sul suo blog e su Facebook. E’ un verde-blu iridescente che, attraversando la gamma dei colori, pare sfumare nel diafano da cui ci invia riflessi di figure, sovrimpressioni, fantasmagorie. Ecco: la trasparenza è un’altra caratteristica dei versi di Cristina Bove, nel senso intuitivo del termine (poiché si tratta di figure luminose, leggere, sfumate) ma anche in quello del confine sottile che passa tra riflessione e rifrazione di un raggio di luce. Del punto cruciale in cui un medium qualsiasi, in parte assorbe e in parte riflette il messaggio luminoso. Così come la memoria riflette l’evento rifrangendolo nelle molteplici tangenti delle sue figurazioni inconsce. Quella di Cristina Bove è anche una poesia della trasparenza e della soglia, una esplorazione dei limiti del diafano nel linguaggio: una videoarte del dire.
La sapiente variazione dei suoi versi equivale all’intero gradiente di rifrazione dei corpi al messaggio della luce. In questo senso, anche le figure del suo discorso assumono la valenza di una fantasmagoria in cui trascendenza e immanenza si incontrano come il riflesso e la frattura di una immagine in un punto sulla superficie della rappresentazione. Pertanto le figure in sospensione nei versi di Cristina Bove si possono considerare anche come degli ologrammi, delle produzioni sul foglio di carta di immagini tridimensionali, attraverso il reticolo di diffrazione dei suoi versi. Ologrammi metafisici che coniugano riflessione e rifrazione, trascendenza e immanenza, manifestazione ed essenza del nostro essere al mondo. In una sapiente orchestrazione della “toccata e fuga di se stessi” (44), tra valenze aforistiche e chiusure epigrammatiche, tra sottolineature e motteggi, nonsense e paradossi.
Il lievitare misurato della parola rigenerata (logos egeneto), il fraseggio accurato, l’equilibrio di una versificazione interstiziale in cui la espressione sapiente riunisce la mascherata della vita e quella dell’arte, facendone un bilancio lucido e mirabile, spassionato e implacabile, realistico e visionario, dove nell’umana confessione si può leggere talora in palinsesto una dichiarazione di poetica. (54) Il fraseggio di Cristina Bove si svolge in una fluttuazione caratteristica tra l’espressione linguistica come manifestazione dell’esserci e il suo fondamento nullo, cioè anche tra figura e fondo, linguaggio e silenzio. In questo senso, la sua è una poetica del tratteggio e della sottrazione, dell’adombramento e della sospensione sistematica di ogni (pre)giudizio di esistenza. Una fenomenologia e una ermeneutica della finitezza e dell’impermanenza, a tutti gli effetti, che spesso si esprime per calembours e paradossi, intesi come controlli severi ed esperimenti cruciali sui limiti del nostro linguaggio e della visione del mondo che su di esso si basa. L’insieme di questi giochi linguistici converge graficamente poi verso il punto, da una parte e il trattino basso, dall’altra. La punteggiatura, nella poesia di Cristina Bove in generale, risulta pressoché assente ma tale assenza indica il suo esser tra le righe, il suo essere stata completamente assorbita (sospesa, messa in mora, epochizzata) nel fraseggio e nella versificazione. O se si preferisce nel fondo del suo dettato poetico. Tranne che nell’unico caso, nella presente raccolta, in cui compaiono dei puntini di sospensione (61) a marcare l’irrazionale poetico. O in quello, assolutamente singolare, della poesia dal titolo esplicito, “.mettere un punto” (86), dove il punto appare in posizione anomala, a inizio frase, e messo in correlazione coi trattini bassi che compaiono nell’ultimo verso del componimento. L’uso del trattino basso è invece estremamente frequente, nell’intera poesia di Cristina Bove, fungendo quasi da supplemento alla punteggiatura rarefatta e indicandone infine lo sprofondamento nell’abisso della dizione. I trattini bassi, vera e propria ossessione grafica della nostra autrice, croce e delizia dei suoi editori, non sono certo un vezzo ma costituiscono il tratto distintivo della sua versificazione, il suo svolgersi al limite dello spro-fondamento del discorso, del riassorbimento delle figure della espressione (Ausdruck) sul fondo (Abgrund) della nuda vita. L’uso del trattino basso, il tratteggio ritmico-semantico che funge da basso continuo della sua versificazione, costituisce inoltre la condensazione grafica di quel fraseggio (Ausdruckweise) e di quella lievitazione del dire (Schweben) che ho indicato all’inizio e che caratterizzano in modo inconfondibile la sua poesia. Mentre il punto anomalo è qui manifestazione grafica della coincidenza delle varie prospettive, o fasci di luce coerente riflessi-rifratti dal s/oggetto della rappresentazione, a costituire quella configurazione ologrammatica del discorso che ne rappresenta un’altra caratteristica saliente. Il punto, infine, qui segna il limite di quella funzione di dis/orientamento al mondo che è propria della poesia in generale, ma che qui assume tutti i connotati di una ascesi della parola e di una sobria composizione del luogo del discorso attraverso un costante esercizio di eliminazione del superfluo, in una pratica della sottrazione che è da attendersi in una poeta che è anche scultrice e il cui alter ego, in una recente raccolta, appare come “Una donna di marmo nell’aiuola”.
*
Per corroborare la linea ermeneutica adottata, sarà ora opportuno fornire alcuni esempi di ordine tematico-strutturale. A partire proprio dalla messa a punto della propria poetica che Cristina Bove compie nella poesia prima menzionata (“.metter un punto”) e che val la pena citare per intero, per dare una idea dello spessore e della consapevolezza del suo dire: “Per solidificare la parola estinta/_il suo vissuto termina sul foglio_/magari farle un monumento/solo di interpunzioni/dedicarlo ai poeti che non scrivono/ Mi ci metto/perché non ho mai scritto un bel silenzio/perché non ho saputo eliminare/una vita di sillabe/ mi arrendo nel mimare un’esistenza/_tra due trattini stesi_”. (86) Questa lirica è nel contempo un compendio della sua poetica e una convalida di quanto abbiamo osservato: tutta giocata com’è sulla linea d’ombra, sulla lievitazione tra vita e forma, mondo e linguaggio, cose e parole: su quello schweben che abbiamo menzionato all’inizio e che implica anche una sorta di sospensione del giudizio di esistenza (o epoché trascendentale) del mondo ricevuto, che qui viene messa a tema e in forma, tutta racchiusa fra il punto anomalo dell’inizio e i due trattini stesi alla fine, che insieme sottolineano e sdoppiano, sottendono e mettono in mora, il valore dell’enunciato, cioè della loro stessa verbalizzazione. Questo per dire tutta la sottigliezza, complessità, condensazione, humour, ironia e lucidità di cui è capace Cristina Bove. Che qui in partenza si esercitano sullo statuto stesso della poesia, “la parola estinta” in quanto “il suo vissuto termina sul foglio” e dunque anche il luogo in cui la vita trapassa e si fissa nella parola. E su quello dei poeti, che vengono chiamati in causa con elegante sprezzatura, come coloro che nutrono “una vita di sillabe” ma che non riescono mai a giungere al cuore del reale galleggiando sulla superficie del discorso. Una sprezzatura che però presto si volge in autoironia poiché lei stessa afferma di non aver mai “scritto un bel silenzio”.
In questi versi, metricamente calibrati e variati, vien fuori la perfetta congruenza tra la fluttuazione metafisica e il fraseggio poetico, come tratto fondante e distintivo della versificazione di Cristina Bove. E si tratta di una declinazione singolare e memorabile di quello Unter-Schied (differenza-relazione o interferenza fra linguaggio e mondo) che per Heidegger costituisce il sostrato della poesia in quanto tale e che qui nel testo di Cristina Bove si traduce graficamente nell’uso insistito del trattino basso. Si tratta dunque di una messa a punto onto-logica del proprio dire che si esprime poi in un metro e in una sintassi meravigliosamente esatti e variati, in un minidramma della ipostasi della parola scritta che, fra peripezie e riconoscimenti, squisitamente infine si arrende al silenzio che la attende. Per cui questa ironia che non fa sconti, questa umanissima certificazione dei propri limiti, umani e poetici, finisce per tramutarsi infine, in virtù del suo proprio stesso disincanto, in una muta domanda che esprime tutta la pietà del pensiero. E infatti, nel componimento seguente, il tratteggio poetico rivela la trama esistenziale da cui è sotteso: “le questioni mai risolte/tra la vita e la morte” (87). Quella sospensione dei mortali che sanno di “esistere per poco” e null’altro sapendo sospettano di essere solo “sogni/di un dio che ad ogni suo risveglio/ha già dimenticati.” (ibid.)
Ma la fluttuazione ontologica è endemica nella poesia di Cristina Bove, e i suoi tratti ritornano in una molteplicità di profili e intagli come accade, con evidente allusione alle opere di Lucio Fontana, nella poesia “Fontaniana” appunto, dove il taglio della tela di un quadro appare come un “varco tra pensiero e corpo” (83) e pertanto assume la valenza metafisica del frammezzo, “la zona franca aperta sulla tela” fra essenza e apparenza, in quel continuo dialogo fra essere e coscienza che si svolge nei suoi versi, senza che le due parti possano mai veramente scindersi né coincidere, (“_perché il male ci dispensa dall’amalgama_”), (ibid.) come monadi che danzano alla cieca il ballo in maschera dell’esistenza, in bilico sul filo del rasoio, in attesa di una finale messa a punto di cui ignorano il tempo e il luogo. Questa arlecchinata metafisica ha peraltro già avuto un’esposizione magistrale nella splendida “Maestri (s)concertatori” dove “in un emiciclo di ripercussioni”, (44) l’intera sinfonia dell’esserci appare intesa a “lustrare gli occhi spersi di chi sa/che tutto muore/come le note già suonate/nella toccata e fuga di se stessi.” Su questa stessa pratica della espressione fenomenologicamente sospesa sul fondamento nullo dei suoi trattini bassi, del fraseggio come correlativo verbale del frammezzo esistenziale tra dettaglio e disegno, nomi e cose, essere e coscienza, si veda per esempio anche l’impeccabile umorismo di “Inquilini e scalatori” dove ci si può esprimere solo “Per interposta ragnatela”, (53) perché “non si trova il modo/di dare un altro nome a ciò che accade”, e ci si trova “intrappolati ai muri e ai versi”, presi in tenzoni futili, quasi dimentichi che “tanto sarà per poco” e che ci tocca “nel frattempo/vivere di miracoli a ritroso/esserci quanto basta”. E dove infine la charis (grazia, dedizione e cura) di ogni dire risulta funzionale a riempire il frattempo che ci divide dall’attimo fatale.
L’equivalenza tra frammezzo esistenziale e fraseggio verbale, viene sviluppata ancora nella lirica che segue, “Considerando il dentro e il fuori”, dove la sinfonia dell’esistenza trova ulteriori accordi nel tenore metapoetico del testo e la commedia umana nuovi scenari, (tra dentro e fuori, tra essere e coscienza), un intero copione di metafore gastronomiche che riconducono l’ispirazione poetica alla sua base organica, mentre la poesia appare ancora una volta come farmaco (rimedio-veleno) contro il male di vivere: “sta quasi per accendersi la festa/si pronuncia l’antitodopoesia da bocca a bocca” per render il “mondo commestibile” e chiudere gli occhi sui “_transiti scatologici_”/di questa mascherata cromosomica/che ci consegna ad un perenne oblio.” Mentre “l’aria che si annida negli alveoli, ad ogni inspirazione/incendia le apparenze e ci consuma/ malgrado innumerevoli varianti, siamo carboni ardenti”. (54) La ironica e spassionata demistificazione dell’arte sfocia infine, nella lirica seguente, in quella della religione, dove “il dio dei fallimenti programmati/in palinsesti onirici” (55) per non farci accorgere “che non esiste porto/né un orizzonte per colare a picco”, viene rappresentato in tutta la sua comica impotenza mentre “è lì che aspetta il sorgere del mondo”.
Su questi incroci prospettici fra realtà e rappresentazione, si producono dunque quelli che ho chiamato gli ologrammi poetici di Cristina Bove, nel senso degli incroci di prospettive o di raggi laser sull’oggetto che appare così traslucido e multidimensionale. Ma anche nel senso di una inclusiva grammatica della creazione che sa mettere insieme dettaglio e disegno, in una fantasmagoria dell’esistenza che è nel contempo lucidissima e visionaria. Questo “Paradigma ologrammatico” (significativo anche in vista delle sue applicazioni all’arte digitale di Cristina) trova d’altronde una esatta definizione nella lirica eponima, dove lo sdoppiamento e la fluttuazione ricorrente fra essere e coscienza, dettaglio e disegno, micro e macrocosmo, trovano una messa a tema e una definizione esplicita: “è che assistiamo/_contemporaneamente_/ad ogni tempo della nostra vita/il vivere e il morire a ogni momento/essere il sognatore ed il suo sogno” perché “di fronte ad uno schermo/siede il frammento e tutto l’universo” (50): un disegno frattale impeccabile che va ad arricchire l’ologramma poetico-esistenziale, in cui lo sdoppiamento di essere coscienza, reso in una costante variazione aspettuale e prospettica, distillato nell’alambicco di un linguaggio senza fronzoli, genera quella geometrica veggenza che caratterizza la poesia di Cristina Bove: “immagine riflessa _pupille come fori_/negli occhi innumerevoli e diversi/attraversati dalla stessa luce/un solo aspetto/eppure il tutto riversato in esso/nell’illusoria percezione che/ci si veda soltanto un po’ per volta”. (ibid.) E qui si nota chiaramente come l’oscillazione caratteristica del dettato di Cristina Bove, non riguarda soltanto i diversi livelli di realtà ma anche l’ordine temporale dell’accadere, muovendosi tra due tagli verticali (Kairoi), l’attesa dell’evento ineludibile della morte e il ricordo non già della nascita, ma di un evento traumatico, di un tentato suicidio, in una notte “del trentuno agosto/che lei precipitò dalla ringhiera/e poi si addormentò sul marciapiede” (83). Evento che assume però qui i connotati gnostici della metempsicosi, di una caduta dell’anima nella prigione del corpo, segnando l’inizio di quel dialogo fra sé e sé, di quello sdoppiamento, prospettico ed esistenziale, e di quella veggenza che caratterizzano la poesia di Cristina Bove: “io me ne andai/lasciandola sul posto_ venni al mondo/pagandomi l’accesso dal balcone.”, “Però le ho sempre raccontato tutto/e lei non ha mai smesso di volare/_non si ricorda d’essere atterrata_/:sogna di me piombata sull’asfalto/sagoma disegnata con il gesso/e nel suo sogno lei si crede viva/ed io nel mio fingo d’essere morta”. (ibid.) Questo dialogo fra self and soul, che mi ricorda una splendida poesia di W.B. Yeats, costituisce l’arco teso su tutta la poesia di Cristina Bove, l’arcobaleno iridescente che contiene tutte le sfumature della sua veggenza e i magnifici doni che essa sa offrirci, e che a mio parere fanno di lei uno dei maggiori poeti viventi, ancora in attesa di un pieno e doveroso riconoscimento.

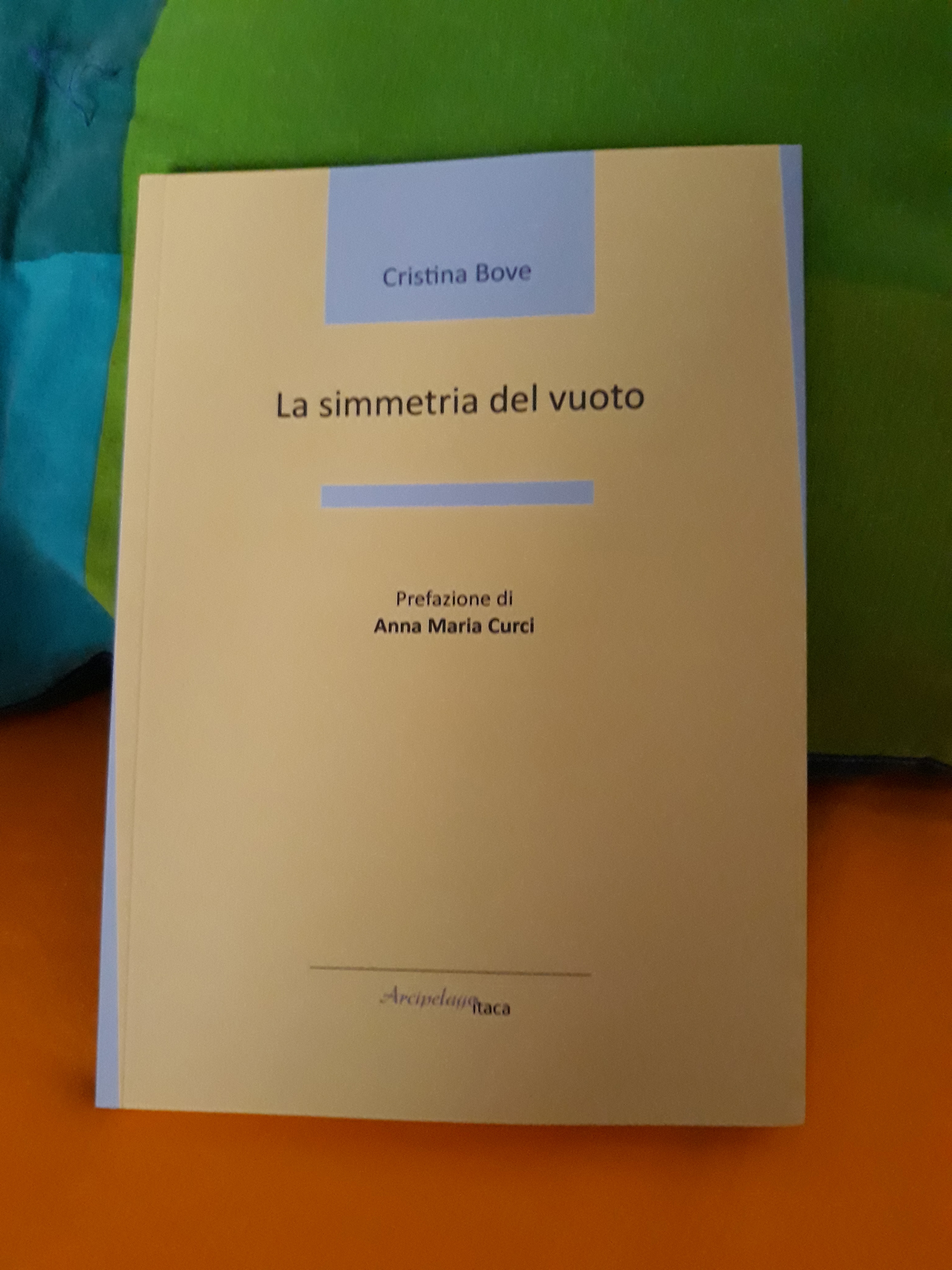
Nessun commento:
Posta un commento